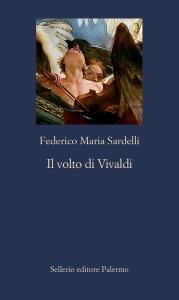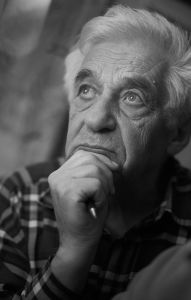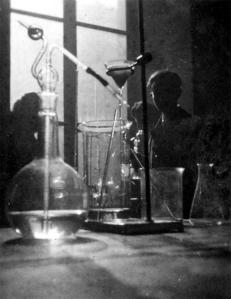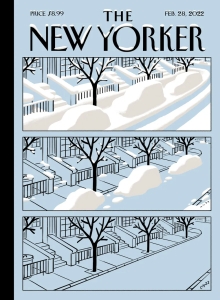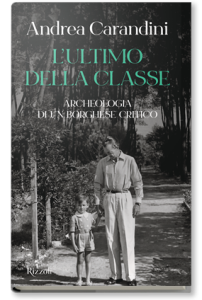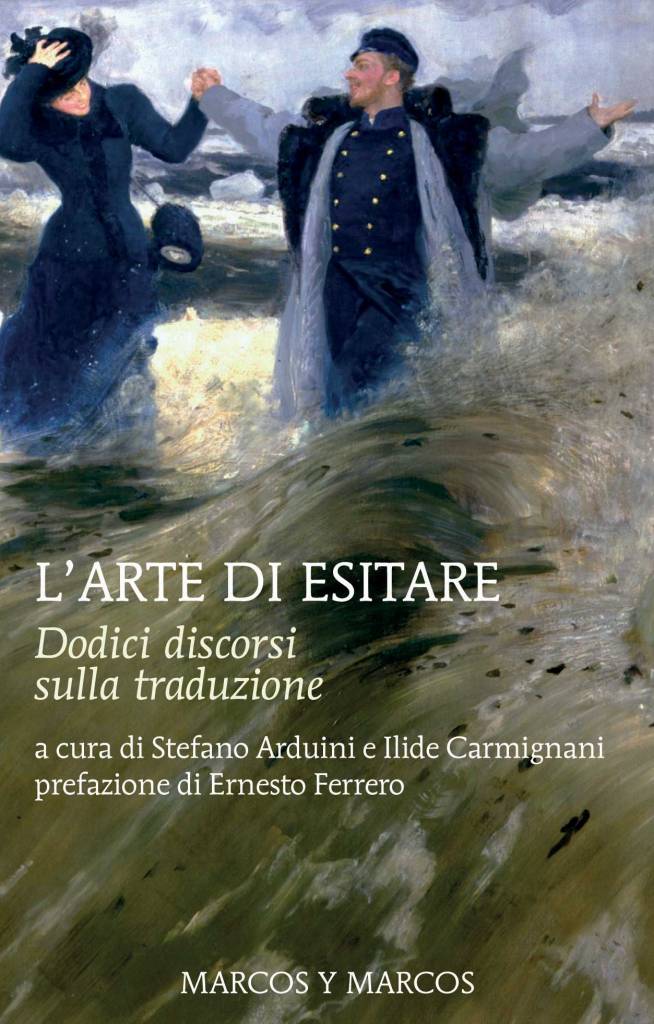Vivaldi prestò servizio alla Pietà sia come maestro di violino (e molti altri strumenti) che come compositore, lungo tutto l’arco della sua vita, fino al 1740, pur in un’altalena di licenziamenti e riassunzioni. La prassi voleva infatti che ogni anno i maestri venissero riconfermati con una votazione (ballottazione) fra i governatori; la precarietà di questo servizio discendeva da un imperativo di ferreo risparmio: un maestro non serviva più non appena le «figlie» fossero state messe in grado di fare da sole. La complessa e funzionale gerarchia interna delle «figlie» consentiva una costante e omogena trasmissione del sapere musicale dalle più grandi alle più piccole, dalle più istruite alle principianti. Tuttavia, per quanto ben congegnato, questo meccanismo non poteva prescindere dall’apporto esterno dei maestri: dopo qualche anno essi dovevano esser riassunti, non appena il livello qualitativo delle esecuzioni del «coro» cominciava a deteriorarsi.
Federico Maria Sardelli, Il volto di Vivaldi, Sellerio (2021)