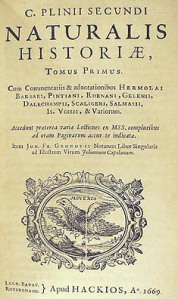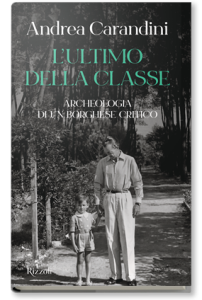All’altro estremo della città, verso Sud-Ovest, Erode fece costruire il nuovo palazzo reale: «i suoi edifici superarono persino il Tempio in ampiezza e splendore», dice Giuseppe Flavio. Vicino sorgevano tre torri chiamate Hippicus (dal nome d’un amico), Phasael (in ricordo d’un fratello), e Mariamne (in memoria della moglie). Parti della base di una delle torri sono visibili ancora oggi. Il bugnato di grosse pietre rozzamente scalpellate, che dona alle pareti un’espressione di forza rupestre, è tipico delle costruzioni del periodo erodiano. Pare che questa tecnica costruttiva sia stata riportata in Europa dai crociati; è possibile che i palazzi di Firenze (Strozzi, Pitti, Riccardi e via dicendo), con la loro aria tra fortilizio e residenza, abbiano qualche remota parentela stilistica con la Gerusalemme d’Erode.
Fosco Maraini, Le pietre di Gerusalemme, a cura di Maria Gloria Roselli, Il Mulino (2022). Nella foto (Wikimedia) a sinistra una parte della torre di Phasael.