
La noia è una visuale sulle proprietà del tempo che uno tende a ignorare, mettendo possibilmente in pericolo il proprio equilibrio mentale. È una finestra sull’infinitudine del tempo. Una volta aperta questa finestra, non provate a chiuderla; al contrario, spalancatela.
Iosif Brodskij citato da Michael C. Corballis in The Wandering Mind, The University of Chicago Press (2015), traduzione L.V. Nella foto (Stanford University) Iosif Brodskij.
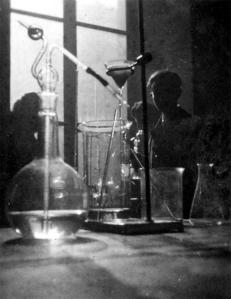




 Gli scienziati hanno idee differenti su come acquisiamo la lingua parlata. All’idea che siamo tabulae rasae molti preferiscono l’ipotesi che le nostre abilità verbali abbiano una base evolutiva e biologica. Tutti però concordano sul fatto che impariamo la lingua in gran parte con l’ascolto. Scrivere è certamente un’abilità appresa e non un istinto: semmai, come mi hanno insegnato anni di esperienza professionale, l’istinto è di guardare Twitter, passare l’aspirapolvere, finire le parole crociate del Times o fare qualunque altra cosa pur di evitare di mettersi a scrivere. A differenza della scrittura, il parlare non ha bisogno di un certo numero di bozze prima che “funzioni”. L’incertezza, l’ansia, la paura e la fatica mentale sono tutti stati d’animo presenti alla scrittura; parlare, invece, è facile, spesso piacevole e per lo più automatico e inconsapevole.
Gli scienziati hanno idee differenti su come acquisiamo la lingua parlata. All’idea che siamo tabulae rasae molti preferiscono l’ipotesi che le nostre abilità verbali abbiano una base evolutiva e biologica. Tutti però concordano sul fatto che impariamo la lingua in gran parte con l’ascolto. Scrivere è certamente un’abilità appresa e non un istinto: semmai, come mi hanno insegnato anni di esperienza professionale, l’istinto è di guardare Twitter, passare l’aspirapolvere, finire le parole crociate del Times o fare qualunque altra cosa pur di evitare di mettersi a scrivere. A differenza della scrittura, il parlare non ha bisogno di un certo numero di bozze prima che “funzioni”. L’incertezza, l’ansia, la paura e la fatica mentale sono tutti stati d’animo presenti alla scrittura; parlare, invece, è facile, spesso piacevole e per lo più automatico e inconsapevole. Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e tradizionale, un’abitudine gratificante, una ginnastica mentale, un modo obbligatorio e compulsivo di riempire i vuoti di tempo, e una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza. Mio padre aveva sempre in lettura tre libri contemporaneamente; leggeva «stando in casa, andando per via, coricandosi e alzandosi» (Deut. 6.7); si faceva cucire dal sarto giacche con tasche larghe e profonde, che potessero contenere un libro ciascuna.
Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e tradizionale, un’abitudine gratificante, una ginnastica mentale, un modo obbligatorio e compulsivo di riempire i vuoti di tempo, e una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza. Mio padre aveva sempre in lettura tre libri contemporaneamente; leggeva «stando in casa, andando per via, coricandosi e alzandosi» (Deut. 6.7); si faceva cucire dal sarto giacche con tasche larghe e profonde, che potessero contenere un libro ciascuna.