Lo psicologo Paul Bloom, nel libro dal titolo Descartes’ Baby, si spinge fino a suggerire che siamo effettivamente nati per essere dei dualisti filosofici, come lo era lo stesso Cartesio, e per credere che la mente sia separata dal corpo. Il dualismo, suggerisce Bloom, è innato.
Questo non vuole ovviamente dire che le nostre menti siano separate dai nostri corpi: è solo che siamo predisposti a crederlo. È davvero difficile convincere la maggior parte delle persone, eccetto noi baldi psicologi e materialisti neuroscienziati, che siamo semplicemente creature di carne e ossa, con processi fisici all’interno delle nostre teste che dettano i nostri pensieri e le nostre azioni. La fede nel dualismo, ossia l’idea che la mente possa sfuggire al corpo e ai vincoli del mondo fisico, è del resto un aspetto del pensiero errante.
Michael C. Corballis, The Wandering Mind, The University of Chicago Press (2015), traduzione L.V. Nella foto (Wikipedia, no Fronteiras do Pensamento) Paul Bloom.




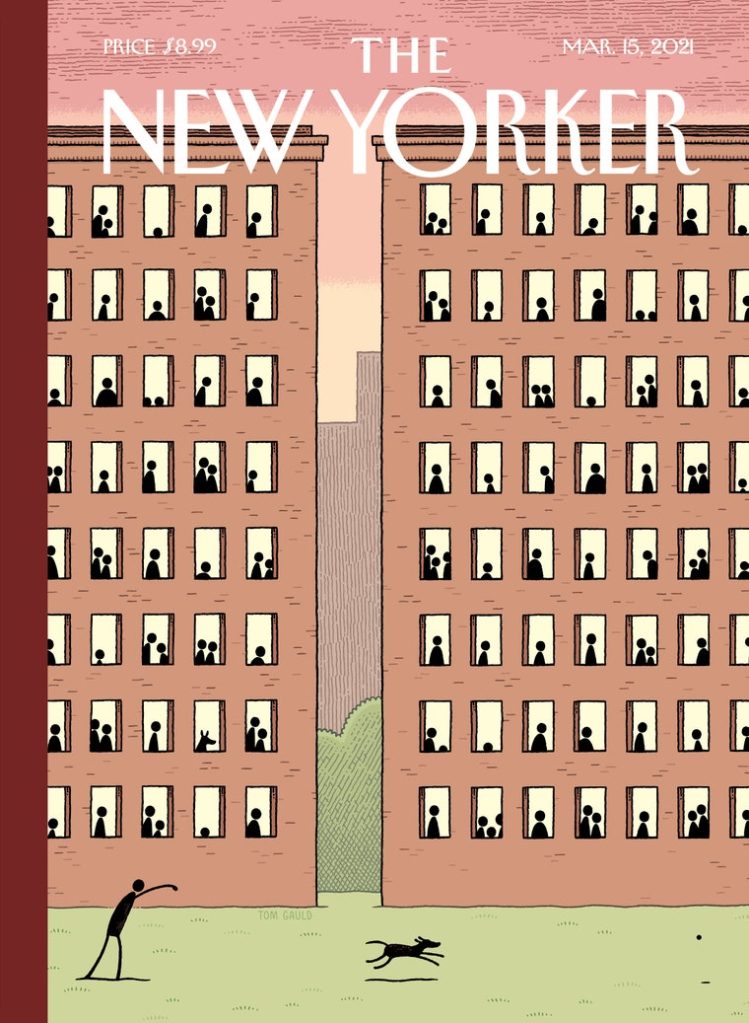


 “Ci siamo sempre tenuti alla larga dalla politica industriale, ma potremmo ritrovarci nella necessità di fare investimenti pubblico-privati, o solo pubblici, per la ‘democrazia del 5G’, ha dichiarato il senatore Mark Warner.
“Ci siamo sempre tenuti alla larga dalla politica industriale, ma potremmo ritrovarci nella necessità di fare investimenti pubblico-privati, o solo pubblici, per la ‘democrazia del 5G’, ha dichiarato il senatore Mark Warner.