

A proposito degli spazi vuoti, sia in Degas che in De Nittis vi è un aneddoto interessante. Il dipinto di De Nittis La place de Pyramides reca, al centro, tre figure che rappresentano il visconte Ludovic Lepic, amico di De Nittis e di Degas, con le sue due figlie. Vediamo lo stesso trio nel quadro di Degas Place de la Concorde. Il visconte Lepic con le sue due figlie. Quest’ultimo non fu mai esposto, e pare che Degas l’avesse venduto proprio all’amico Ludovic. Quando l’intera collezione di Lepic andò all’asta, nel 1879, il catalogo della vendita lo attribuì al nostro De Nittis. Il mercante Paul Durand-Ruel, accortosi dell’errore, acquistò l’opera e molti anni dopo la vendette a un collezionista tedesco. L’opera passò poi in mani sovietiche e oggi è esposta al Museo di San Pietroburgo.
Renato Miracco, dal saggio nel catalogo della mostra De Nittis pittore della vita moderna, a cura di Fernando Mazzocca e Paola Zatti (Silvana Editoriale), Palazzo Reale, Milano (9/6/2024). Nelle foto, a sinistra, Giuseppe De Nittis, La place de Pyramides (1875, Wikipedia, Musée d’Orsay), a destra, Edgar Degas, Place de la Concorde. Il visconte Lepic con le sue due figlie (1875, Wikipedia, Museo Hermitage, San Pietroburgo).
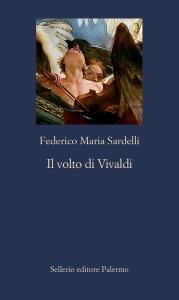

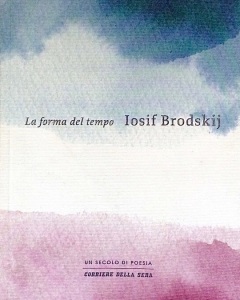

 L’ansia di incontri sempre nuovi agita la sua immaginazione. Egli li cerca ovunque: a un ballo di corte, per strada, in una locanda, a teatro, in un postribolo. Passa con disinvoltura da una città all’altra senza calcoli, senza un piano. Il suo percorso viene deciso da un paio di begli occhi che l’hanno fissato un istante più del dovuto. E per un paio di begli occhi egli è capace di travestirsi da servitore di locanda, di dare banchetti, di recitare La scozzese di Voltaire e di mettere radici in una minuscola cittadina svizzera. In un breve arco di tempo riesce ad amare un’aristocratica del gran mondo, le figlie di un oste, la monaca di un monastero di provincia, una colta fanciulla abile nelle dispute teologiche, le inservienti dei bagni bernesi, la seria e graziosa Dubois, un’attrice di rara bruttezza e, dulcis in fundo, persino l’amica gobba di quest’ultima.
L’ansia di incontri sempre nuovi agita la sua immaginazione. Egli li cerca ovunque: a un ballo di corte, per strada, in una locanda, a teatro, in un postribolo. Passa con disinvoltura da una città all’altra senza calcoli, senza un piano. Il suo percorso viene deciso da un paio di begli occhi che l’hanno fissato un istante più del dovuto. E per un paio di begli occhi egli è capace di travestirsi da servitore di locanda, di dare banchetti, di recitare La scozzese di Voltaire e di mettere radici in una minuscola cittadina svizzera. In un breve arco di tempo riesce ad amare un’aristocratica del gran mondo, le figlie di un oste, la monaca di un monastero di provincia, una colta fanciulla abile nelle dispute teologiche, le inservienti dei bagni bernesi, la seria e graziosa Dubois, un’attrice di rara bruttezza e, dulcis in fundo, persino l’amica gobba di quest’ultima.