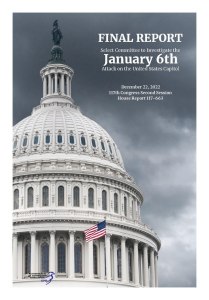Lo psicologo Paul Bloom, nel libro dal titolo Descartes’ Baby, si spinge fino a suggerire che siamo effettivamente nati per essere dei dualisti filosofici, come lo era lo stesso Cartesio, e per credere che la mente sia separata dal corpo. Il dualismo, suggerisce Bloom, è innato.
Questo non vuole ovviamente dire che le nostre menti siano separate dai nostri corpi: è solo che siamo predisposti a crederlo. È davvero difficile convincere la maggior parte delle persone, eccetto noi baldi psicologi e materialisti neuroscienziati, che siamo semplicemente creature di carne e ossa, con processi fisici all’interno delle nostre teste che dettano i nostri pensieri e le nostre azioni. La fede nel dualismo, ossia l’idea che la mente possa sfuggire al corpo e ai vincoli del mondo fisico, è del resto un aspetto del pensiero errante.
Michael C. Corballis, The Wandering Mind, The University of Chicago Press (2015), traduzione L.V. Nella foto (Wikipedia, no Fronteiras do Pensamento) Paul Bloom.