A quel tempo l’isola di Cuba era un abisso assonnato che inghiottiva soldati; e siccome i volontari che si arruolavano per il servizio d’oltremare erano sempre più insufficienti, gli ufficiali che reclutavano nella Penisola ricorrevano a ogni genere di stratagemmi, anche i più ripugnanti ed infami. A tal fine, gli agenti del reclutamento non si facevano scrupolo dal frequentare le case da gioco e le osterie, e quando un opportuno stato di ebbrezza era stato raggiunto, arruolavano non solo tutti i vagabondi e i degenerati, ma anche i giovani stranieri che cadevano nelle loro grinfie. Arrivarono così a Cuba alcuni sfortunati artisti savoiardi, che all’epoca vagavano per la Spagna cantando l’inno di Garibaldi accompagnandosi con l’arpa.
Uno di questi disgraziati italiani approdò nell’infermeria di San Isidro. Soffriva di epatite e idropisia, e inoltre il suo volto itterico mostrava l’impronta indelebile della malaria cronica. Non so come avesse fatto, durante i suoi sfortunati vagabondaggi per l’isola, a custodire il suo prezioso strumento musicale, accanto al quale dormiva in infermeria, timoroso che gli fosse portato via. Questo soldato musicale era un tipo cortese e di buon carattere, e quando la febbre lo abbandonava, ci intratteneva con concerti all’aperto. Con la sua accoglienza aveva guadagnato non solo la nostra gratitudine, ma anche alcuni pesos che teneva da parte in vista del sospirato rimpatrio.
Mi sembra di vederlo ancora al chiaro di luna, il viso giallo, l’espressione abbattuta e triste, e il ventre idropico, un tocco morboso che gli dava un aspetto tragicamente grottesco. Posto al centro del gruppo di ascoltatori, con il corpo appoggiato al tronco di un albero, produceva con precisione e sentimento romanze di Rossini e Donizetti, canti napoletani e arie della Savoia soffuse di dolce malinconia, che la nostra fame di musica trasformava in qualcosa di sublime.
Santiago Ramón y Cajal, Recollections of my life, traduzione dallo spagnolo all’inglese di E. Horne Craigie e Juan Cano, MIT Press (1989), traduzione L.V. Nella foto (Cuba Periodistas), a destra, Ramón y Cajal nella divisa di ufficiale medico dell’esercito spagnolo, usata a Cuba. A sinistra, una foto del forte e dell’ospedale di San Isidro, nella regione di Puerto Príncipe, ora Camagüey, dove Ramón y Cajal prestò servizio per un anno durante la Guerra dei dieci anni.


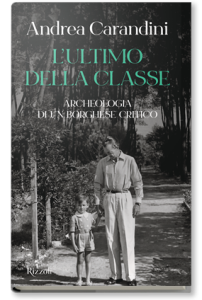
 Sovente ho messo piede su ponti che uniscono (o dovrebbero unire) la cultura scientifica con quella letteraria scavalcando un crepaccio che mi è sempre sembrato assurdo. C’è chi si torce le mani e lo definisce un abisso, ma non fa nulla per colmarlo; c’è anche chi si adopera per allargarlo, quasi che lo scienziato e il letterato appartenessero a due sottospecie umane diverse, reciprocamente alloglotte, destinate a ignorarsi e non interfeconde. È una schisi innaturale, non necessaria, frutto di lontani tabù e della controriforma, quando non risalga addirittura a un’interpretazione meschina del divieto biblico di mangiare un certo frutto. Non la conoscevano Empedocle, Dante, Leonardo, Galileo, Cartesio, Goethe, Einstein, né gli anonimi costruttori delle cattedrali gotiche, né Michelangelo; né la conoscono i buoni artigiani d’oggi, né i fisici esitanti sull’orlo dell’inconoscibile.
Sovente ho messo piede su ponti che uniscono (o dovrebbero unire) la cultura scientifica con quella letteraria scavalcando un crepaccio che mi è sempre sembrato assurdo. C’è chi si torce le mani e lo definisce un abisso, ma non fa nulla per colmarlo; c’è anche chi si adopera per allargarlo, quasi che lo scienziato e il letterato appartenessero a due sottospecie umane diverse, reciprocamente alloglotte, destinate a ignorarsi e non interfeconde. È una schisi innaturale, non necessaria, frutto di lontani tabù e della controriforma, quando non risalga addirittura a un’interpretazione meschina del divieto biblico di mangiare un certo frutto. Non la conoscevano Empedocle, Dante, Leonardo, Galileo, Cartesio, Goethe, Einstein, né gli anonimi costruttori delle cattedrali gotiche, né Michelangelo; né la conoscono i buoni artigiani d’oggi, né i fisici esitanti sull’orlo dell’inconoscibile.